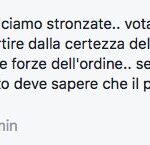“Vedo che sei uno dei gran coglioni di sinistra cui piace il negrone”.
“…Per le figlie femmine prepariamo gia il burka che tra qualche anno dobbiamo farglielo mettere però – pace e bene…anzi…inshalla”.
“Difendila dai nuovi invasori. Potrebbe essere tua madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia”.
Sono tanti gli spettacoli di meschinità quotidiana che incrociamo continuamente sul web, costruiti sulle suggestioni della cronaca, imboccando senza pentimenti le strade dell’odio, della discriminazione, dell’intolleranza.
Post, spesso sgrammaticati, che sono il caleidoscopio di una parte della nostra società, prigioniera dei luoghi comuni, frustrata, tragicamente ignorante e che in rete dà il peggio di sé.
La rete, che è diventata la valvola di sfogo degli imbecilli, una zona franca per gente che non staresti ad ascoltare nemmeno sotto anestesia.
Uno dei risvolti più gravi di tutto questo vomitare imbecillità è che vengono meno le potenzialità per cui la rete è nata: offrire nuove forme di partecipazione sociale.
La violenza verbale uccide l’interazione e ci riporta indietro ai tempi del medium a senso unico. Questo perché, quando ci si trova davanti a un muro di insulti, alla fine si smette di rispondere, ci si disconnette.
È così che si distruggono i social e si limita la libertà personale dell’altra fetta di utenti del web, quelli che usano il cervello.
Eppure le grandi compagnie si tirano fuori.
È di Mark Zuckerberg la frase: “We are a tech company and not a media company”, come a negare ogni responsabilità di quello che gli utenti postano sulla piattaforma Facebook.
Come a negare che i social facciano parte del discorso pubblico e necessitino di controllo.
Non è che questa indulgenza è dovuta al fatto che certi argomenti generano traffico? Un po’ come per il meccanismo di certe ignobili trasmissioni tivvù, che fanno audience perché gridano tutti?
Si tratta di considerazioni che nascono da un fastidio, tutto personale, verso questa umanità urlante che è riuscita a entrare in possesso del megafono del mondo e ora ci costringe a subire tutto il suo repertorio.
Simona Tarzia
Sono una giornalista con il pallino dell’ambiente e mi piace pensare che l’informazione onesta possa risvegliarci da questa anestesia collettiva che permette a mafiosi e faccendieri di arricchirsi sulle spalle del territorio e della salute dei cittadini.
Il mio impegno nel giornalismo d’inchiesta mi è valso il “Premio Cronista 2023” del Gruppo Cronisti Liguri-FNSI per un mio articolo sul crollo di Ponte Morandi. Sono co-autrice di diversi reportage tra cui il docu “DigaVox” sull’edilizia sociale a Genova; il cortometraggio “Un altro mondo è possibile” sul sindaco di Riace, Mimmo Lucano; “Terra a perdere”, un’inchiesta sui poligoni NATO in Sardegna.